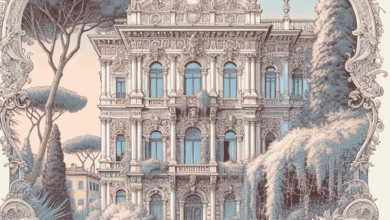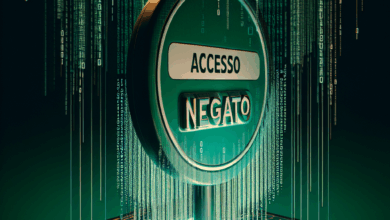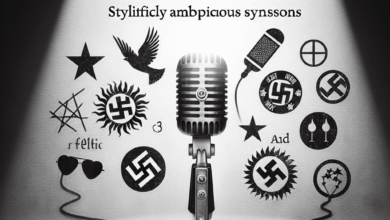Una carriera sfortunata nell’illusione degli italiani.

Il «Sentiero delle rimembranze e della solidarietà», che circonda la città di Lubiana per quasi 30 km, oggi percorribile in bicicletta, segue il tracciato che l’esercito italiano aveva delimitato con filo spinato alla fine di febbraio del 1942, trasformando la città, annessa all’impero fascista, in un vasto campo di internamento. Questa misura si affiancava a una severa politica repressiva nei confronti del movimento partigiano jugoslavo, sotto la direzione del generale responsabile, che si macchiò di numerosi crimini di guerra contro la popolazione civile.
La figura di questo generale e la mancata epurazione dei vertici dell’esercito italiano sono oggetto di un’analisi storica approfondita, che esplora i reati degli italiani durante le guerre fasciste, la loro impunità e la loro rimozione dalla memoria collettiva.
Capo del Servizio Informazioni Militari dal 1934 al 1939, sostenitore delle forze franchiste durante la guerra civile spagnola e interlocutore privilegiato del regime nazista, il generale fu autore della segnalata «Circolare 3C», emanata nel marzo del 1942, che prescriveva misure feroci contro i partigiani jugoslavi.
Il generale guidò l’occupazione fascista nei Balcani con una repressione severa, affiancandosi a militari noti per la loro brutalità, alcuni dei quali, come un altro generale, rimasero impuniti e si ritirarono a vita privata senza affrontare processi.
Al termine del conflitto mondiale, il nome di questo generale figurò come primo nella lista di richieste di estradizione dal governo di Belgrado per crimini di guerra, ma la richiesta non fu accolta, complici i nuovi equilibri geopolitici europei e la Guerra Fredda. Ciò precluse la possibilità di un processo simile a quello di Norimberga in Italia, consentendo la persistenza delle gerarchie fasciste e dei vertici più coinvolti nella violenza del regime.
Il caso del generale fu emblematico: nominato Capo di Stato Maggiore durante il fascismo e confermato dopo l’8 settembre, venne rimosso nel 1943 sotto pressione anglo-americana e arrestato nel 1944. Divenne capro espiatorio per la fuga del governo e la mancata difesa di Roma dall’occupazione nazista. Tuttavia, il processo per lui si trasformò in un momento di contestazione dei vertici statali, contribuendo a un “paradigma dell’impunità”, legato alla continuità dello Stato e alla difesa delle istituzioni, e all’azione dilatoria nei processi per i crimini tedeschi commessi in Italia.
Durante il processo, fortemente influenzato da ragioni di Stato, il quale rischiava di accusare il fascismo e i suoi leader, il generale evase, grazie a complicità e coperture nazionali e internazionali. Condannato in contumacia all’ergastolo, pena poi annullata, la sua figura continuò a influenzare la politica italiana attraverso le sue connessioni con mondi monarchici e militaristi.
La memoria del passato è influenzata da due forze: l’oblio e la trasformazione della memoria. Tra queste forze si colloca l’analisi del generale, che evidenzia come la rimozione del passato abbia ostacolato la ricerca storica e la riflessione critica sulla memoria del Paese, ancora condizionato dal mito degli «Italiani brava gente», un mito smontato con rigore e impegno civile nel corso dei decenni.