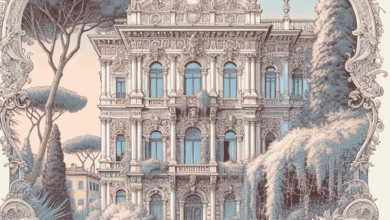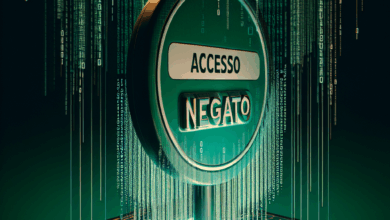Presa della Bastiglia: la rivoluzione francese ci coinvolge

Il 14 luglio si ricorda la Presa della Bastiglia, una data simbolica della rivoluzione francese e dei suoi ideali di libertà, uguaglianza e fraternità. Questo evento ha suscitato numerosi spunti di riflessione sulla società contemporanea.
La Presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio 1789 a Parigi, ma la rivoluzione era già iniziata a Versailles a fine giugno dello stesso anno. Un momento cruciale fu il Giuramento della Pallacorda del 20 giugno 1789, quando i rappresentanti del Terzo Stato si autoproclamarono "Assemblea Nazionale", giurando di non sciogliersi fino all’adozione di una nuova Costituzione. Questo segno di rottura con la monarchia assoluta rappresentò un cambiamento epocale.
Il Terzo Stato, convocato dal re Luigi XVI per affrontare la crisi finanziaria e politica, rifiutò i canoni dell’antica forma consultiva, perseguendo una nuova Costituzione e leggi più giuste. Nel frattempo, la popolazione iniziava a sensibilizzarsi e politicizzarsi. L’alfabetizzazione crescente favorì la diffusione di opuscoli e periodici, portando alla consapevolezza della situazione del Paese. Gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità divennero fondamentali per la rivoluzione, conducendo all’abolizione della monarchia assoluta e all’emergere di un nuovo ordine repubblicano.
La carestia e l’aumento dei prezzi esasperarono il popolo, alimentando timori circa la volontà del re e dei ceti privilegiati di affamare la popolazione. La comunicazione quotidiana su ciò che accadeva a Versailles contribuì all’allerta della popolazione parigina. Gli intellettuali, come avvocati e giornalisti, informarono il pubblico e sollevarono preoccupazioni, mentre la borghesia di Parigi si organizzò in una municipalità insurrezionale.
Questa municipalità cercò di armarsi e si rivolse alla Bastiglia per ottenere polvere da sparo. La giornata fatidica del 14 luglio vide una folla armata avvicinarsi alla fortezza, mentre una delegazione tentava di negoziare l’approvvigionamento. L’assalto iniziò dopo un’esplosione, nonostante la resistenza della guarnigione. Alla fine, la Bastiglia fu espugnata, liberando prigionieri politici e portando alla giustizia degli ufficiali.
La borghesia e il popolo trovarono un coordinamento difficile, con la municipalità borghese che temeva anche l’alleanza popolare. La dimensione politica della rivoluzione era caratterizzata dall’idea di uno Stato che non fosse più fondato su privilegi, ma su cittadini uguali. Il coinvolgimento popolare durante la Presa della Bastiglia fu massiccio e il luogo divenne simbolico, segnando l’inizio di ulteriori azioni rivoluzionarie.
Il 26 agosto 1789 l’Assemblea Nazionale approvò la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, come risposta a un movimento popolare diffuso in tutto il Paese. Questo portò all’abolizione del sistema feudale, a una nuova società più egualitaria e alla fine dei privilegi della nobiltà e del clero.
Il re resistette alla Dichiarazione e, nel 1789, le donne parigine, esasperate dalla mancanza di cibo, marciarono su Versailles, costringendo la famiglia reale a tornare a Parigi. Le donne, pur non avendo diritti politici, parteciparono attivamente al movimento. Olympe de Gouges scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna, chiedendo uguaglianza giuridica e politica, ma la sua posizione rimase minoritaria.
Nel 1793, scoppiano insurrezioni, come quella in Vandea, e il conflitto si intensificò con l’ingresso della Francia in guerra contro Austria e Prussia. Le emergenze belliche portarono a un’inflazione che colpì il movimento popolare. I giacobini, sostenuti dai sanculotti, presero il controllo del governo, instaurando una fase di radicalizzazione e terrore.
Il periodo vide giustizie sommarie, con l’esecuzione di vari leader, mentre il governo tentò di adottare alcune rivendicazioni popolari. Tuttavia, alla fine, si tornò a un suffragio maschile censitario, limitando le conquiste democratiche raggiunte.
L’eredità della rivoluzione include l’idea di una democrazia "larga" e il principio della giustizia sociale, estendendo l’imposizione progressiva e la redistribuzione del reddito. Questi principi influenzarono la cultura politica del XIX secolo, ma oggi sembrano poco presenti nella scena politica, dove la partecipazione e la giustizia sociale sono spesso trascurate.