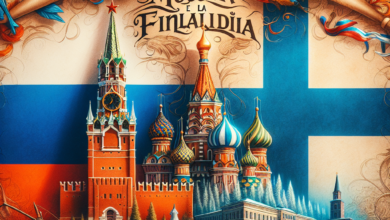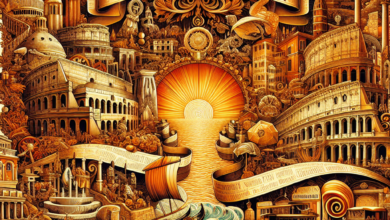L’Europa riscopre la guerra e la sua fragilità strategica.

L’illusione del “dividendo della pace” ha lasciato l’Europa impreparata al ritorno della guerra. L’invasione russa dell’Ucraina ha imposto di ripensare la Difesa non come un esercito europeo alternativo alla Nato, ma come una cooperazione rafforzata e una politica estera comune.
04/11/2025
Fin dall’antichità, l’Europa è stata segnata da continui conflitti, con un’alternanza tra brevi periodi di pace e lunghe fasi di guerra. Dalla Guerra dei Trent’anni alle Due Guerre Mondiali, i conflitti più sanguinosi della storia umana si sono originati in Europa.
Dopo il crollo del Muro di Berlino, si è creduto che il rischio di un conflitto di massa fosse azzerato e che l’Europa potesse finalmente incassare il “dividendo della pace”. Le spese militari sono state drasticamente ridotte per finanziare il welfare o abbattere il debito, poiché investire in Difesa richiede capitali ingenti e tempi lunghi per ottenere risultati. I politici, concentrati sul ciclo elettorale di 4-5 anni, preferivano investire in settori con risultati più immediati, lasciando la sicurezza in mano agli Stati Uniti tramite la Nato.
L’attenzione si è spostata su missioni di peacekeeping e gestione delle crisi, piuttosto che sulla Difesa territoriale. Ciò ha reso meno urgente per i leader europei comprendere le dottrine militari e la logistica della guerra. Molti partiti considerano l’uso della forza militare come ultima risorsa e privilegiano diplomazia e sanzioni per regolare i conflitti. L’Unione Europea ha valorizzato l’esperienza economica e regolatoria a discapito di esperti di strategia militare.
L’invasione dell’Ucraina nel 2022 ha rappresentato un “richiamo alla realtà”, dimostrando che desiderare la pace non è sufficiente per garantirla. Molti Paesi, come la Germania, hanno annunciato significativi aumenti delle spese per la Difesa. La strategia di deterrenza è tornata al centro del dibattito, sebbene la competenza in materia rimanga in fase di sviluppo.
Il dibattito sulla Difesa Europea è ora penalizzato da superficialità e incompetenza, impedendo di mettere in comune anche i fatti più evidenti. 23 dei 27 Paesi dell’UE fanno parte dell’Alleanza Atlantica e hanno approvato il concetto strategico che identifica le minacce e definisce la strategia di deterrenza dell’Alleanza.
È evidente che ogni discussione deve partire da ciò che è già condiviso, e la Difesa europea deve essere integrata alla Nato. L’idea di creare un esercito europeo alternativo è fuorviante. La vera necessità è sviluppare capacità comuni attraverso un comando e controllo integrati e un procurement condiviso.
La Nato utilizza le Forze Armate nazionali senza doverle unificare, grazie a dottrine e standard comuni che risolvono il problema dell’interoperabilità. Tuttavia, manca una politica estera europea condivisa per decidere come impiegare le Forze Armate.
La questione centrale riguarda la possibilità che i Governi europei possano concordare modifiche ai trattati comunitari per condividere la politica estera, rinunciando al diritto di veto. Chi sostiene questa possibilità non ha una visione realistica della situazione.
L’autonomia strategica implica la capacità di operare senza dover chiedere aiuto esterno, senza compromettere le alleanze. L’Europa deve colmare le proprie lacune in tecnologie abilitanti, come comunicazioni, difesa missilistica, trasporto militare e protezione delle infrastrutture critiche. Non è realista pensare che si possa spendere di meno per ottenere di più; l’accordo Nato per l’aumento degli investimenti nella Difesa è funzionale all’obiettivo dell’autonomia strategica europea.