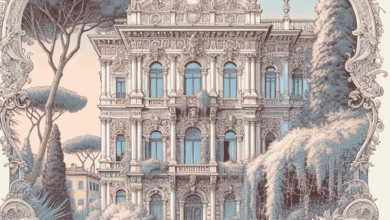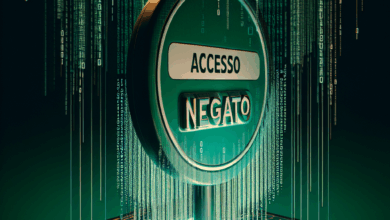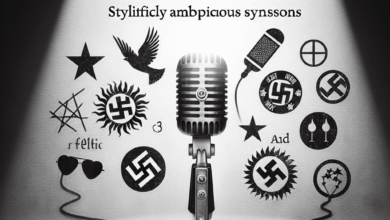Le domande indispensabili da porre.
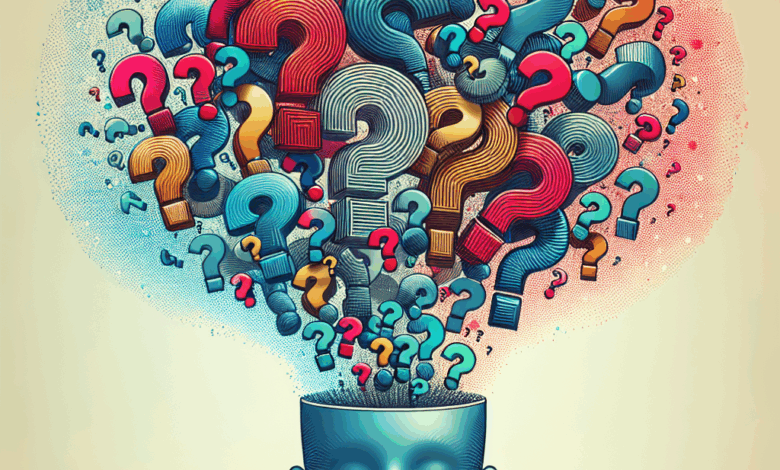
La situazione nella Striscia di Gaza, caratterizzata dall’azione dell’esercito israeliano in risposta agli eventi del 7 ottobre 2023, sta alimentando un incremento dell’antisemitismo a livello globale, con un focus particolare sull’Europa. L’attacco alla Chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza, che ha causato morti e feriti tra cui il parroco, mette in evidenza l’assurdità del contesto attuale. Il patriarca di Gerusalemme ha rimarcato l’assurdità di tale guerra, sottolineando che ogni giorno si registrano perdite umane. La tensione corrente mette a rischio anni di dialogo ebraico-cristiano, con molte voci critiche nei confronti delle scelte governative israeliane che sembrano essere ignorate.
Si presenta quindi la necessità di interrogarsi sulla coscienza cristiana circa il ruolo dell’ebraismo nella costruzione della cultura e della civiltà europea. Alcuni principi fondamentali dell’ethos occidentale sono radicati nella tradizione ebraica, come la concezione di una storia orientata verso un eschaton e la relazione con un Dio unico. Innumerevoli figure dell’ebraismo hanno contribuito notevolmente alla nostra crescita sociale e culturale.
Come vivere la relazione fra ebraismo e cristianesimo in questo periodo storico? È plausibile aspirare a una maggioranza silenziosa in Israele pronta a lavorare per una pace autentica? Le differenze tra le posizioni di leader israeliani sono un segnale di una possibile evoluzione in temi complessi. È fondamentale continuare a sognare una coesistenza pacifica tra i due popoli sullo stesso territorio. Il contributo dei cristiani in Terra Santa e nel mondo è potenzialmente cruciale, poiché è chiaro che Israele e la Chiesa, pur essendo entità distinte, sono indissolubili nella fede. Appelli alla pace hanno trovato eco tra le presenza cristiane in Terra Santa, spingendo a un movimento di opinione che unisca diverse comunità religiose globali per favorire il dialogo e la collaborazione.
La via della riconciliazione non può prescindere dal riconoscimento del diritto di Israele a esistere in pace. Allo stesso tempo, è necessario che la presenza araba in Terra Santa si distacchi dalla sua connessione con Hamas. Qui, le comunità cristiane possono avere un ruolo significativo, riconoscendo i diritti inalienabili degli israeliani e delle varie componenti arabe.
Questa prospettiva è riflessa nella Dichiarazione tra Gerusalemme e Roma, adottata nel contesto del cinquantesimo anniversario di Nostra Aetate, che ha modificato il rapporto della Chiesa cattolica con le altre fedi. Le domande che ne derivano sono inevitabili: quale importanza ha per i cristiani l’esistenza del popolo ebraico? Come affrontare la responsabilità dell’antisemitismo? Qual è il modo migliore per integrare l’amore verso Israele con l’accoglienza per tutti i popoli? In che modo una maggiore comprensione dell’ebraismo e dell’islam possa contribuire a una riconciliazione duratura? È importante che anche i cristiani chiedano ai loro interlocutori ebrei cosa renda questo percorso più agevole e giusto.
Infine, la riflessione su come collaborare per ottenere patti di pace giusti e veritieri è urgente e necessaria. A seguire l’invito a perdonare le offese ricevute, possiamo costruire un futuro di pace. La strada è complessa e richiede impegno e apertura al dialogo interreligioso.
Arcivescovo di Chieti-Vasto