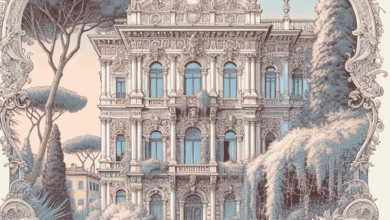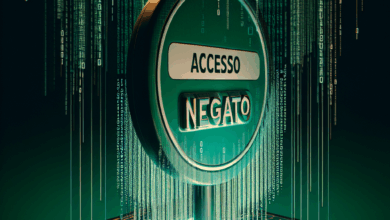Klein: connessioni inaspettate | il manifesto
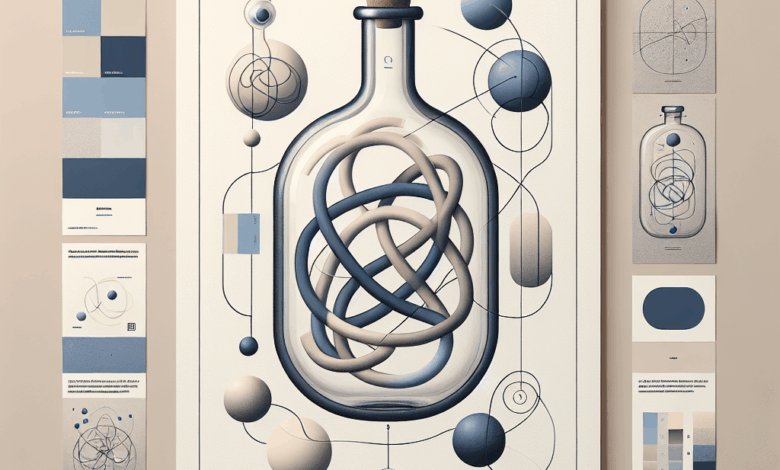
Per introdurre Klein, si potrebbe affermare che fu uno di quegli studiosi in grado di dar vita a una nuova disciplina. Sotto l’egida della storia dell’arte, indagò un campo ibrido, a cavallo tra storia delle idee, letteratura, teorie artistiche ed estetica. Finì così per fondare una “disciplina che, a differenza di tante altre, esiste ma non ha nome”.
È facile presentarlo in questi termini, soprattutto considerando una battuta originale su Aby Warburg, attribuita a Klein. Tuttavia, questa affermazione risulta parziale. Sebbene oggi sia poco conosciuto tra i filosofi, questo studioso di origine rumena non nacque come storico dell’arte, ma come filosofo. La sua opera, vista in questa luce, affronta questioni filosofiche senza la rigidità tipica del termine. Il progetto che lo accompagnò durante le sue trasmigrazioni – da Timisoara a Firenze, passando per Bucarest, Praga e Parigi – era quello di redigere una grande Estetica, centro attorno a cui ruotano le sue pubblicazioni storico-artistiche.
La decisione di ripubblicare la raccolta di saggi La forma e l’intelligibile, scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, è particolarmente significativa. Essa rende nuovamente accessibile quest’opera straordinaria e la libera da una settorialità che ha limitato la sua ricezione.
Il volume si divide in quattro sezioni principali: il pensiero e il simbolo nel Rinascimento, la storia della prospettiva e della scienza, l’estetica e il suo metodo, e infine, l’etica. Tuttavia, l’elenco non rende giustizia alla varietà dei temi trattati. Lo studioso che analizza il ruolo degli “spiritelli” nella poesia tardo-medievale è lo stesso che riflette sui limiti della morale trascendentale e sui tarocchi illustrati del Quattrocento, concludendo sull’eclissi della critica e dell’arte nel contesto contemporaneo.
Ciononostante, non è tanto la varietà dei temi che sorprende, quanto la capacità di scoprire connessioni inaspettate. Ogni fenomeno, sotto il suo sguardo, rivela la propria natura nascosta. Per esempio, la Commedia di Dante esprime un nucleo sciamanico, trattando il viaggio nelle sfere superiori come un’esperienza iniziatica.
Un’idea del secolo dei Lumi, come il carattere immaginario dell’Inferno, si rivela influenzata da antiche teorie neoplatoniche sullo pneuma phantastikon, il quale forma gli incubi dell’anima peccatrice nell’aldilà. L’arte religiosa della Controriforma, che afferma che i quadri generano un “contagio affettivo”, mostra la sua dipendenza dall’estetica magica di Giordano Bruno. E così via: intuizioni fulminee pervadono un volume che, nonostante tutto, riesce a fornire una solida interpretazione del Rinascimento italiano.
Oltre alla ricostruzione burckhardtiana, Klein delinea un’epoca di tensioni e opposte spinte, in cui il mito dell’homo faber si contrappone all’antropologia celeste dell’Accademia fiorentina, che considera l’uomo come soggetto contemplativo. Questi due modelli sono destinati a incontrarsi.
Così, mentre il reale e il fantastico si bilanciano in Mantegna, in Filippino Lippi già si disgiungono, con la rêverie che prevale. La scoperta delle grottesche, ornamento della Domus Aurea, ha certamente accelerato questa tendenza. Da quel momento, l’imitazione dell’Antico diventa motivo per liberare la fantasia.
Masaccio appare meno distante da Van Eyck di quanto si pensasse, e la Primavera botticelliana già si volge verso una stagione definita “autunno del Medioevo”. Il decorativismo del tardo Cinquecento rivela una tendenza già presente nel secolo precedente. Dopo aver messo in discussione le opposizioni facili tra Nord e Sud, Klein rifiuta l’idea di un Rinascimento unicamente platonico, evidenziando l’importanza di Padova come centro dell’aristotelismo.
Si interroga quindi sul rapporto tra arte e teoria, avversando il formalismo di Wölfflin, che non coglie il bisogno di “leggere” le opere. Se l’aristotelismo ha ispirato un’estetica, non è quella della pittura veneta, ma quella manierista. Come evidenziato nella sua tesi L’Esthétique de la techné, recentemente riesumata, nel Cinquecento l’estetica del virtuosismo emerge dall’aristotelismo.
Tuttavia, il Manierismo non si limita al periodo dal XVI agli inizi del XVII secolo. In un’ottica più ampia, esso indica un modo di concepire il rapporto tra forma e contenuto nell’opera d’arte, rappresentando una particolare maniera di essere e produrre, che diventa il paradigma di ogni etica.
Ogni tentativo di classificazione si rivela subito insufficiente, richiedendo una visione più complessa. Klein coglie analogie tra periodi e fatti lontani, superando la logica del debito e della filiazione. Simile a un altro eretico del Novecento, Klein sembra condividere la visione che comprendere un fenomeno significhi collocarlo in una costellazione. Ecco che Pico, come Sartre, riconosce l’uomo come l’unico ente per cui l’esistenza precede l’essenza.
Per Klein, comprendere una teoria implica anche misurarne la verità. Così, il suo saggio sull’Inferno in Ficino si conclude con una critica a un’idea che attribuisce a ciascuno la responsabilità delle proprie azioni come conseguenza naturale. Essendo il sistema giudiziario umano inadeguato, Klein sottolinea che la consapevolezza morale non può derivare da fattori esterni. L’etica risiede nel riconoscimento della responsabilità.
Nel contesto storico-artistico, il circolo ermeneutico è un elemento fondamentale per ogni lettura iconografica, mentre la tautologia morale va oltre un solipsismo tragico. La coscienza, ritirandosi, si apre agli altri. Un saggio sul riso, su cui Klein lavorò prima della sua morte, rivela che la solitudine di chi ride non è isolamento, ma una forma vitale di comunicazione.