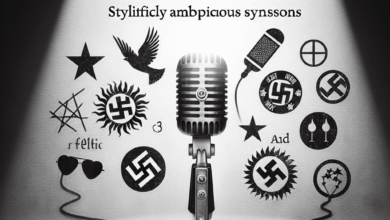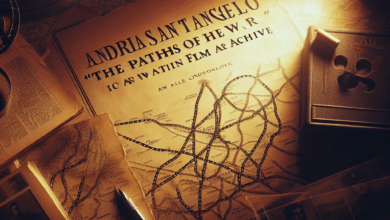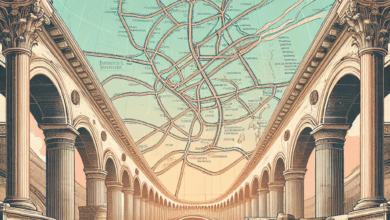Il mito del conflitto inevitabile va sfatato. Ribelliamoci!
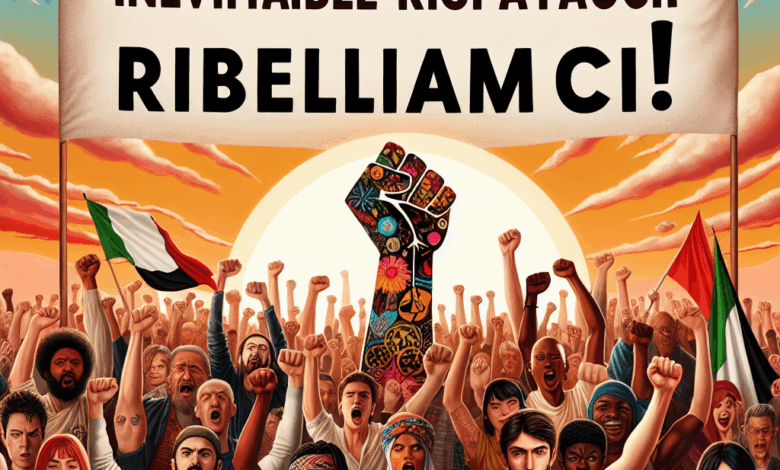
Ineluttabile. Questa parola si insinua nei nostri pensieri, trasformandosi da paura indistinta a dubbio sussurrato nei discorsi, fino a diventare una certezza che si accetta: «La guerra è inevitabile». Questa idea si diffonde silenziosamente, creando un consenso mormorato, un primo passo verso la resa. Con il passare del tempo, questo pessimismo si solidifica, e la guerra smette di essere una tragedia per diventare un destino. Tuttavia, la guerra non è un destino: è una scelta, una scelta che si costruisce giorno dopo giorno, comportamento dopo comportamento. Come richiamato da figure istituzionali, ci si può ritrovare su un crinale pericoloso, dove la violenza può emergere anche senza intenzioni. È in questa distrazione quotidiana, nell’apatia e nel fatalismo che risiede il rischio maggiore. Non è vero che un anno come il 1914 debba ripetersi. Ci sono momenti nella storia in cui l’umanità ha bloccato il disastro: dalla crisi di Cuba nel 1962, dove non scoppiò la guerra malgrado la tensione, alla crisi di Suez nel 1956, in cui si trovò una soluzione anche in un contesto di grande complessità.
Più avanti, il Muro di Berlino cadde senza sparare un colpo, una sorprendente dimostrazione che l’inevitabile può disintegrarsi sotto il peso della volontà e della responsabilità. Anche l’abisso, se osservato con lucidità, può diventare un limite oltre il quale non si decide di andare. La guerra è una costruzione collettiva e, di conseguenza, può essere anche una rinuncia collettiva. Non si tratta di eliminare la violenza dalla vita, ma si può e si deve aspirare a smantellare la guerra come istituzione e strumento di politica. Si vive spesso come se la guerra fosse certa, quando invece si dovrebbe operare un rovesciamento di questa convinzione. È fondamentale resistere al cinismo, rifiutare la narrazione dell’inevitabile e accendere la coscienza. Chi afferma che le parole buone non vengono ascoltate ha già scelto il silenzio e l’irrilevanza, generando impotenza. Tuttavia, non siamo impotenti. Possiamo decidere come comunicare, pensare e agire, mantenendo viva quella inquietudine morale che distingue il cittadino dal suddito. Se l’inquietudine dei cittadini si attenua, i governanti rischiano di diventare dominatori piuttosto che servitori. Questa inquietudine deve disturbare, deve far male, così come non è sufficiente commentare sarcasticamente le azioni del potere. La storia ci ha mostrato momenti di grande follia, ma oggi è importante non diventare spettatori passivi, né cinici senza idee. Questo è il nuovo potere: un’autorità che prospera sull’assenza di responsabilità. La guerra non è inevitabile, è possibile senza dubbio, ma deve essere combattuta. Non con armi, ma con lucidità, impegno e voce. Attraverso la politica e la cultura, a partire da una memoria viva e dal coraggio di non abituarsi. È essenziale resistere all’inerzia verso l’abisso. L’ultima eco del fatalismo non è saggezza, ma un vuoto morale e spirituale. È lì che tutto termina: quando ci convinciamo che non si può fermare la guerra. Questa convinzione segna la nostra sconfitta. È essenziale credere che la guerra possa essere annullata. Non da soli e non in un giorno, ma cominciando da questo momento.