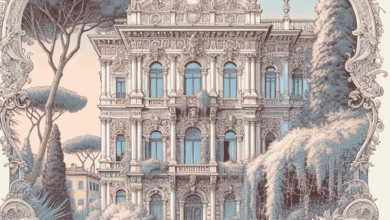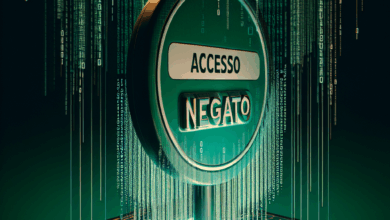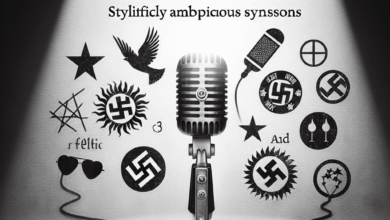Il generale Roatta e il fascismo dimenticato.

Nella Conferenza di Pace di Parigi del 1946, tutte le responsabilità della disfatta vennero attribuite a Mussolini, ai gerarchi e a Vittorio Emanuele III. Una volta eliminati i primi e disposta la monarchia attraverso il referendum del 2 giugno, l’Italia tentò di riacquistare la sua integrità politica e morale, usando la Resistenza come alibi per assolversi dalle colpe del Ventennio.
Tuttavia, alla fine del conflitto, si preferì non affrontare il passato per opportunismo e convenienza. Un esempio emblematico si trova nella figura di Maria Roatta. Capo del Servizio informazioni militari dal 1934 al 1939, partecipò alla guerra civile spagnola al fianco di Franco e, una volta tornato in Italia, ricoprì ruoli di rilievo nel comando militare. Ordinò deportazioni di civili e partigiani jugoslavi e, dopo la caduta del fascismo, fu nominato capo di Stato Maggiore dal governo Badoglio. La sua fuga da Roma e il fatto di non essere mai stato processato per le sue azioni nei Balcani sollevano interrogativi sulle sue responsabilità, sancite poi da un’amnistia nel 1946.
Il “caso Roatta” è emblematico della transizione italiana dal fascismo alla democrazia, dove la classe dirigente si trasferì senza difficoltà nella nuova repubblica. Questa normalizzazione impedì di fare i conti con il passato, lasciando inalterata la struttura dello Stato e preservando le cariche di molti tra magistrati, intellettuali e burocrati. Ad esempio, un ex presidente del Tribunale della razza divenne presidente della Corte Costituzionale anni dopo, mostrando come il personale fascista mantenesse le proprie posizioni.
Questa transizione rapida ha creato un’iperbole storica che pesa ancora oggi, poiché non affrontare il passato significa che esso non diventa mai storia. Le polemiche attuali su temi come l’antifascismo, le celebrazioni del 25 aprile e la Giornata della Memoria dimostrano come la democrazia italiana rimanga immatura, intrappolata in un’eredità che continua a influenzare la società.