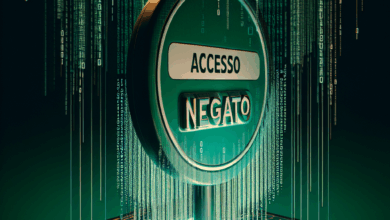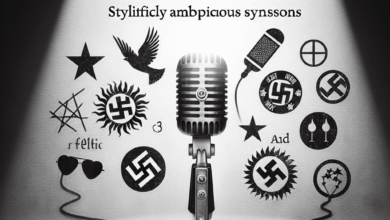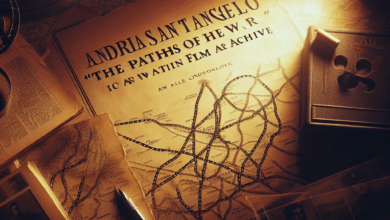Folklore e culto: un nuovo intreccio.

Il folklore è stato per lungo tempo visto come un’espressione delle classi subalterne, in contrasto con gli usi e gli interessi delle classi dominanti. Questo schema binario, sebbene utile, si è dimostrato troppo rigido in contesti storici come il Medioevo, dove le differenze culturali non sempre corrispondono alle stratificazioni sociali. È stato osservato che la frattura principale era tra clero e laici, mentre il sistema culturale rimaneva sostanzialmente unitario, pur con polarità interne.
COLTO E FOLKLORICO non sono mondi separati, ma elementi di un unico sistema, caratterizzato da scambi continui. Ciò ha portato alla «folklorizzazione» di elementi ecclesiastici e alla «volgarizzazione» di motivi teologici. La questione della «religione popolare» ha riflettuto questo dibattito.
Il libro discute come nei primi secoli cristiani il corpo dei martiri divenne oggetto di venerazione: ossa e strumenti di martirio come fonti di grazia e potere. Con la pace costantiniana, il culto si espande e assume un valore politico: possedere reliquie significa prestigio. Le chiese competono per accaparrarsi i resti più venerati, creando una rete di santuari che ridefinisce il paesaggio sacro europeo. Durante il Medioevo, le reliquie raggiungono il loro apice, generando contese tra città e furti sacri, come il caso del corpo di San Marco, trafugato e portato a Venezia, dove divenne il patrono della città.
IL LIBRO DEDICA SPAZIO alle reliquie di Cristo e della Vergine, come il legno della Croce e il culto del Prepuzio, che nel Seicento era molto diffuso. Questa devozione divenne così popolare che la Chiesa dovette limitarla, riflettendo il desiderio di concretizzare il mistero dell’Incarnazione.
Con un altro studio ci si sposta nel campo della Storia scritta «dal basso». Tra i secoli di riferimento, la storiografia era solitamente appannaggio di una ristretta élite, mentre parallelamente si sviluppa un fenomeno sorprendente: autori provenienti da ceti più bassi, spesso semi-alfabetizzati, che registrano esperienze personali accanto a eventi politici e calamità.
Questi testi, privi di ambizioni letterarie, nascono da un desiderio di partecipazione, spingendo a raccontare la propria esperienza della storia. Si possono individuare due gruppi: chi scrive per necessità pratica e chi, pur mantenendo tracce di oralità, si avventura in forme narrative più complesse.
QUESTO FENOMENO avviene in un contesto di profonde trasformazioni, con un aumento dell’alfabetizzazione anche nelle aree rurali, grazie a scuole e attività di parroci. Le cronache popolari trattano la Storia vissuta: guerre, pestilenze e prodigi, presentando racconti ibridi e contaminati da diversi registri. A partire dal XVII secolo, tuttavia, la scrittura pubblica da parte dei non-colti diminuisce, a causa dell’affermarsi di un canone linguistico normativo. Questo non segna la fine della scrittura popolare, ma illustra la creatività della società bassomedievale.