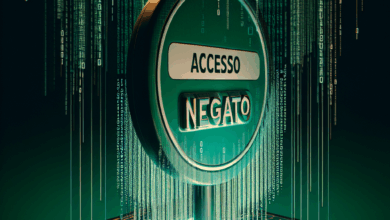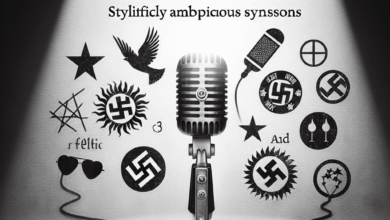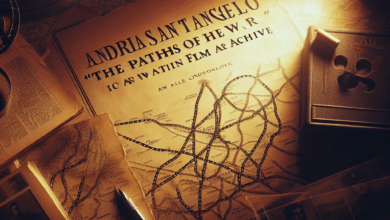Ernesto De Martino: la tensione storica.
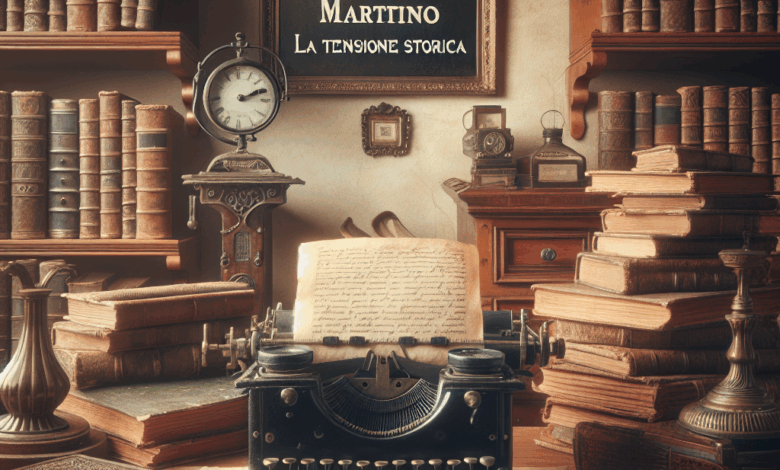
Negli anni recenti sono stati riproposti tre saggi di De Martino, tra cui Note lucane, in cui si analizza la democrazia borghese e la sua relazione con la libertà individuale. De Martino esprime vergogna per aver accettato concessioni che lo hanno reso “libero” a un prezzo inaccettabile. In un altro saggio, Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, sottolinea come il mondo popolare venga percepito come un insieme di cose piuttosto che di persone, rappresentando un problema solo per chi lo domina.
La presenza, secondo De Martino, consiste nella capacità di inseguire memorie ed esperienze utili per affrontare situazioni storiche, mentre la perdita della presenza si manifesta nell’incapacità di scegliere in momenti critici. Dagli anni ’80, il concetto di presenza sembra negato, in un’epoca definita dalla “fine della storia” e della “fine delle ideologie”, dove il dominio sulle civiltà non occidentali è dato per scontato. Hegel parlava di un progresso storicamente lineare verso Occidente, ma oggi assistiamo a un’inversione, continuando a negare i moniti di pensatori come Spengler.
La ricerca umana di superare la perdita della presenza è espressa attraverso miti e riti, strumenti per affrontare l’angoscia della storia. I riti rappresentano un modo per tornare a una comunione con la storia. Il mondo magico, pubblicato nel 1948, esplora questo tema. Dopo l’Olocausto e Hiroshima, emergono opere che trattano il significato e il senso della storia, segnando anni di riflessione per De Martino. Appunti precedentemente pubblicati mostrano la sua complessità filosofica, che si torna a relazionare con le sue considerazioni sul sacro e sui riti di passaggio.
Attualmente, viviamo in una società dominata da ideologie neoliberiste e da un individualismo esasperato. L’ansia e il panico che affliggono le persone sono espressioni di isolamento, dove il senso di appartenenza è quasi assente. La crisi della presenza oggi appare come sofferenza individuale, distante dalla storia e dalla collettività. L’indifferenza verso la morte, insieme a rituali che non riconoscono il loro significato profondo, segna una miseria spirituale presente nella nostra epoca.
L’interpretazione di De Martino sulla reintegrazione sociale in situazioni di crisi della presenza risulta ancora rilevante. Oggi, la nostra crisi sembra negata, e l’idea di un eterno presente privo di sfida storica ci trasforma in bersagli della barbarie contemporanea. Le considerazioni di De Martino sul rapporto tra storia collettiva e individuale rappresentano un punto di vista essenziale per comprendere la nostra condizione attuale.
Comprendere il legame tra storia collettiva e storie individuali, riprendendo spunti da Vico e Heidegger, può aiutarci a rielaborare il nostro vissuto. Dopo il disastro del socialismo reale e nel contesto odierno del capitalismo reale, la riflessione sul rapporto tra individualità e collettività è fondamentale.