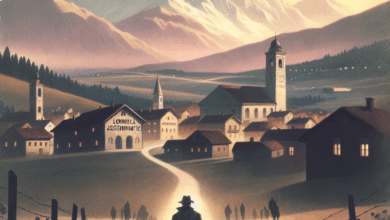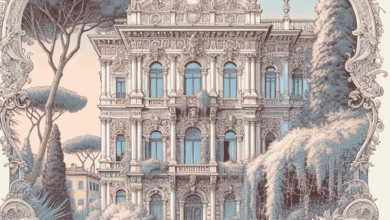Diventare ricchi: nulla di sbagliato, ma pochi ci riescono.

La diseguaglianza viene spesso spiegata attraverso il contrasto tra capitale e lavoro. Un numero ristretto di individui accumula fortune grazie al possesso di ingenti capitali, utilizzati nei mercati finanziari o in attività imprenditoriali. In questo senso, il capitalismo odierno non differisce molto da quello di un secolo fa. Tuttavia, la stratificazione sociale attuale è più complessa, e così anche la distribuzione del reddito e della ricchezza.
È emersa una élite simbolica composta da medici, avvocati, esperti di finanza, consulenti, professionisti dell’high tech, professori universitari e alti dirigenti della pubblica amministrazione. Questa nuova classe sociale, pur posizionandosi sotto i grandi capitalisti, appartiene comunque alla parte alta della piramide socio-economica.
Un tratto distintivo di questa classe è l’essere “woke,” ovvero “attenta” alle questioni sociali come le disuguaglianze, i diritti degli emigrati, le pari opportunità di genere, i diritti del mondo LGBTQ+ e le questioni ambientali. Tematiche che dovrebbero raccogliere consenso, ma che “woke” è diventato, in America in modo aperto e in Europa in modo più nascosto, un termine divisivo. In molte occasioni, l’ex presidente ha dichiarato di volere combattere la cultura “woke” in relazione ai temi di genere e alle preferenze sessuali. Un accademico ha recentemente pubblicato un libro per mettere in evidenza le contraddizioni di questa sensibilità così diffusa.
L’élite simbolica si è costruita una giustificazione morale della sua posizione privilegiata, spesso accompagnata da impegni concreti che rimangono limitati e mai abbastanza radicali da compromettere la propria posizione. Si sente appagata dal contenuto delle sue professioni e considera il proprio lavoro un impegno sociale implicito.
L’élite giustifica il suo vantaggio sociale con idee apparentemente semplici e comprensibili. Cosa c’è di sbagliato nel diventare ricchi? L’importante è farlo onestamente. Tuttavia, non riconosce che la ricchezza di alcuni implica spesso la povertà di altri, soprattutto in un contesto economico stagnante o diseguale. Inoltre, non considera che il merito non è reale se si parte da condizioni fortemente diseguali.
L’emergere di questa élite simbolica può essere interpretato attraverso la lotta di classe. Semplificando, la società è composta da tre classi: chi possiede capitale materiale, chi ha capitale simbolico e la gente comune. In un sistema democratico, le classi privilegiate competono per il potere cercando consenso nella terza classe, che rappresenta la maggior parte della popolazione.
I super-capitalisti stanno prevalendo per diverse ragioni: la globalizzazione, sostenuta dal pensiero progressista, ha aumentato la disuguaglianza nei paesi ad alto reddito; le politiche redistributive della sinistra sono state poco incisive e limitate a una fascia ristretta; e la destra propone idee di rottura più incisive. Inoltre, esiste una contraddizione interna all’élite simbolica: sebbene denunci l’ingiustizia sociale, mantiene una posizione di privilegio. I super-capitalisti appaiono più coerenti.
Queste dinamiche sono accentuate negli Stati Uniti, dove la disuguaglianza è maggiore, c’è meno capitale sociale e le idee liberiste sono più diffuse. Anche in Italia esiste una forte élite simbolica, sotto attacco da una destra tradizionalista, attualmente in fase vincente.
Per coloro che appartengono a questa élite e credono nella lotta contro le disuguaglianze, non è facile capire quale strada intraprendere. Una possibilità è uscire dall’élite, rinunciando ai privilegi e vivendo come la gente comune. Un’altra opzione, più comoda, è impegnarsi attivamente nella vita politica e utilizzare il proprio capitale simbolico per la lotta contro le disuguaglianze. Rimane indiscutibile che l’esempio personale rappresenta un meccanismo di credibilità.