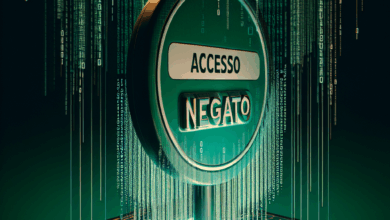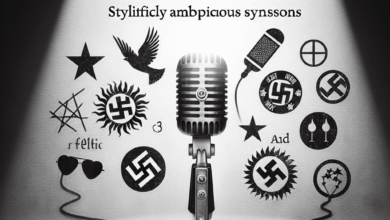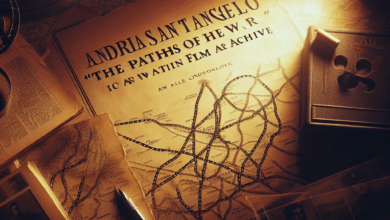Addio a Aldo Zanardo, filosofo marxista di spessore.
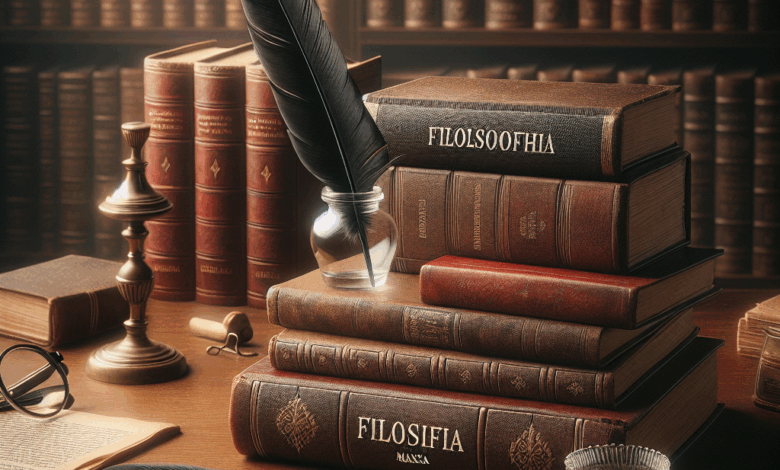
Il 28 agosto a Sesto Fiorentino è venuto a mancare un filosofo profondo e schivo, con un ruolo significativo nella cultura della sinistra italiana, in particolare nel Partito comunista. Nato a Oderzo (Tv) nel 1931, si era formato alla Scuola Normale di Pisa, ascoltando le lezioni di Cesare Luporini, a cui è sempre rimasto legato.
La sua carriera accademica, iniziata negli anni Cinquanta come borsista dell’Istituto italiano di studi storici di Napoli, lo portò prima a Bologna e poi, dal 1969, all’Università di Firenze, dove il suo insegnamento ha lasciato una traccia profonda. Era un importante filosofo marxista e anche attivamente impegnato nell’attività politica e culturale. Consigliere alla Provincia di Firenze e membro del Comitato centrale del Partito Comunista, è stato soprattutto direttore della rivista teorica del Partito, «Critica marxista», dal 1985 al 1991.
Dopo la fine del Pci, ha continuato il suo impegno creando e dirigendo, insieme ad Aldo Tortorella, una nuova serie di «Critica marxista», che attualmente continua le sue pubblicazioni.
Era una figura originale nel panorama filosofico. Il suo interesse principale era il rapporto tra filosofia e socialismo, come indicato nel suo libro pubblicato nel 1974. Sebbene formato in un’epoca di ortodossie, si distanziava dal marxismo ortodosso, ponendo al centro del suo pensiero tre tematiche interconnesse: etica, libertà e individuo.
Con Tortorella, condivideva l’idea che non avesse senso parlare di socialismo senza una base etica. Questo interesse lo portò a studiare il socialismo neokantiano del primo Novecento, dedicandogli un’approfondita analisi. L’etica socialista doveva essere un’etica della libertà effettiva di tutti. La questione della libertà, presente in Marx, sollevava interrogativi su come il marxismo avesse affrontato tali tematiche e se le eventuali insufficienze teoriche potessero spiegare certi esiti politici.
Questa problematica viene affrontata in uno dei suoi saggi più significativi: La teoria della libertà nel pensiero giovanile di Marx, pubblicato nel 1966. Negli anni Sessanta, quando il marxismo appariva come l’orizzonte teorico per decifrare i conflitti dell’epoca, il filosofo sottolineava non solo i meriti, ma anche i limiti della visione marxiana della libertà, considerandola insidiata da un’ottimistica semplificazione dei rapporti tra individui e società.
Avvertiva che la società moderna è composta da individui differenti e irriducibili, e che fosse necessario un grande lavoro teorico per comprendere come potessero ancora trovare ascolto le istanze solidaristiche della tradizione socialista.