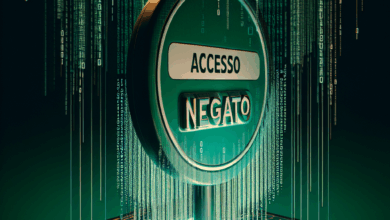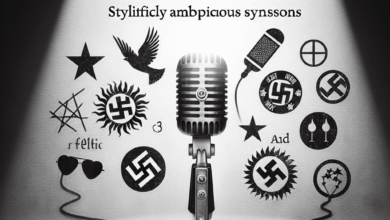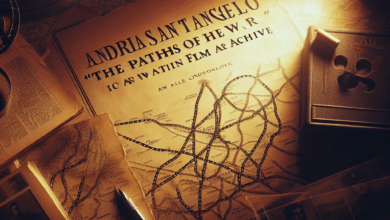109 anni dalla presa di Gorizia: riflessioni attuali

Caro Aldo,
Tra il 6 e il 9 agosto 1916, durante la Prima guerra mondiale, l’Italia ottenne una delle sue vittorie più significative con la presa di Gorizia e del Monte Sabotino. Questo momento rappresentò una svolta decisiva nel conflitto, costata un altissimo tributo di sangue. In tempi incerti, riscoprire il significato di tali eventi fondamentali può rafforzare la consapevolezza del percorso svolto. Tuttavia, la memoria di quei giorni sembra essere svanita dal dibattito pubblico e dalle commemorazioni. Ricordare non equivale a glorificare la guerra, ma a esercitare un atto di consapevolezza storica e civile, come avviene in altri Paesi che sanno integrare le esperienze del passato nel presente.
Cara Maria Luisa,
Hai ragione: ricordare è un dovere morale, soprattutto quando si parla di una vittoria. La presa di Gorizia fu il maggiore successo militare italiano della Grande Guerra, prima della resistenza sul Piave e sul Grappa. Un testimone ricorda i festeggiamenti a Torino per questa vittoria. Il generale Cadorna riuscì a contrastare l’offensiva austriaca sull’altopiano di Asiago e a organizzare rapidamente l’attacco al Sabotino, sorprendendo il nemico. Le truppe presero il Sabotino in trentotto minuti, adottando misure per ridurre il fuoco amico. Il re osservò la scalata, mentre un noto poeta immortalava l’evento nelle sue opere. Si aprì così la via per Gorizia, che venne raggiunta per prima da un sottotenente che afferrò la bandiera e corse verso la città già indifesa. Ricordare è, però, diverso dal celebrare: c’è poco da celebrare riguardo a una guerra che avrebbe potuto essere evitata e condotta con disprezzo per la vita dei soldati. Dopo la Seconda guerra mondiale, Gorizia divenne una linea di confine. La divisione dei due blocchi attraversava la sua stazione. Oggi quel confine è una linea di passaggio all’interno dell’Europa. Tuttavia, le tragedie del passato impongono memoria e rispetto. Gorizia è un tassello di un mosaico complesso. Gli abitanti della area non sono friulani né triestini e hanno un dialetto unico, diverso dal bisiacco parlato a Monfalcone. Una visita recente alle grotte di Postumia ha rivelato storie di famiglie che hanno vissuto in quattro Stati mantenendo lo stesso indirizzo, testimoniando così l’evoluzione della loro identità da austriaca, a italiana, jugoslava e ora slovena — ed europea.
8 agosto 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA