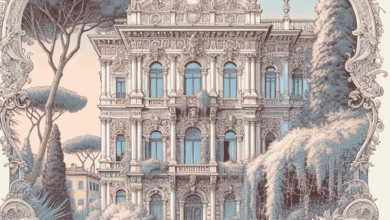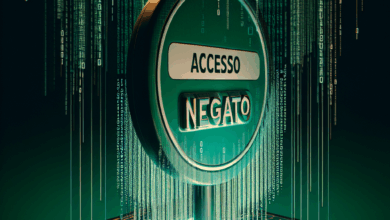“Sono qui con la presente”: Italia e il caos della scrittura.

Anni fa è stato mostrato come il linguaggio della chiesa e del rito cattolico preconciliare abbia influenzato per secoli le classi subalterne, facendo filtrare una forma di latino orecchiato e stravolto, sempre rigenerato dalla fantasia popolare.
Un recente libro svela una realtà simile, evidenziando l’influenza che il testo burocratico, amministrativo e giuridico ha avuto su milioni di parlanti. Questo linguaggio, che per molti funge da ponte verso le forme più basilari di scrittura, ha radici profonde nella storia linguistica italiana.
Un famoso passaggio del 1965 illustra l’incomprensibilità di un verbale di caserma, definito antilingua. La lingua di uffici e tribunali, invece di chiarire, spesso nasconde la verità dietro formule esoteriche, risultando inaccessibile per la maggior parte della popolazione, che ha dovuto misurarsi con il potere attraverso una scrittura che non le apparteneva. A dispetto di questo, oggi la situazione non è troppo mutata.
Le parole di gendarmi e pubblici banditori, le formule di notai e avvocati, e le decisioni di giudici equivalgono per molti a chiavi d’accesso alla lingua scritta. Il linguaggio giuridico-burocratico ha talvolta fornito una struttura a chi affronta il disagio di scrivere, diventando un rifugio per scriventi semi-colti e anche per chi ha un’istruzione più alta ma fatica con il linguaggio scritto. Così, le parole degli oppressori si sono trasformate, seppur distorte, in quelle degli oppressi.
Fin dai tempi dei Placiti campani, chi ha dovuto scrivere in Italia, pur non avendo conoscenze giuridiche, ha spesso attinto alle strutture tipiche di quello che oggi si chiama burocratese. Messaggi di epoche passate mostrano la continuità dell’uso di un linguaggio standardizzato, anche in contesti informali.
La galleria di personaggi descritti nel libro rivela l’uso della lingua tra gli scriventi occasionali, una fascia della popolazione che si trovava tra chi non scriveva e chi scribacchiava. In questa categoria rientrano anche molte donne e uomini che redigevano i propri testamenti, esprimendosi come giuristi anche senza esserlo. La dichiarazione delle ultime volontà, uno dei generi evidenziati, è indicativa della lunga tradizione della scrittura giuridica.
La narrazione del linguaggio giuridico pone attenzione su come forme imposte dall’alto siano state fondamentali nell’educazione e nella diseducazione della popolazione, influenzando il modo di esprimersi in contesti formali e percepiti come tali. Questa evoluzione si riflette anche nei giovani contemporanei, che, pur avanzando nel loro grado di istruzione, continuano a produrre testi influenzati da modelli poco ortodossi.
Il libro tratta anche i materiali di suppliche e lettere di persone comuni, rivelando molto più di quanto si troverebbe in testi più eleganti e accessibili, ma anche più artificiali. Questi scritti, spesso inefficaci o inadeguati, riflettono l’influenza dei testi ufficiali che hanno segnato l’esperienza di chi cercava di dotarsi di una voce attraverso la scrittura.
La questione del “diritto dal basso” si presenta, quindi, come quella di chi non ha diritti, mostrando un panorama complesso di espressioni, toni e stili che parlano della realtà linguistica italiana.