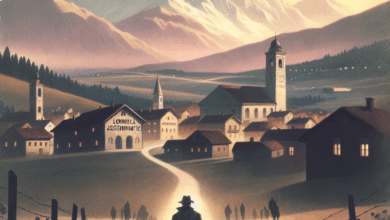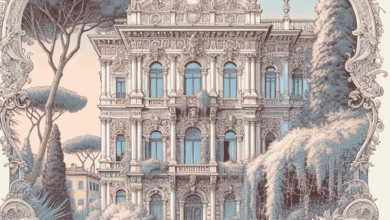Bianchi Bandinelli: l’archeologo attivo nel presente

Cinquant’anni dopo la scomparsa di Ranuccio Bianchi Bandinelli, è interessante riflettere su come le comunità archeologiche e culturali percepiscano oggi una figura così significativa. Quali elementi delle percezioni passate sopravvivono a un contesto radicalmente cambiato? Nell’anno del centenario della sua nascita, riaffioravano ricordi di un intellettuale attento al presente, in netto contrasto con alcuni dei suoi colleghi. Il suo lavoro sembrava anticipare un rinnovamento nel campo dell’archeologia italiana, un seme gettato che ha continuato a dare frutti nel corso degli anni.
Negli anni ’60, molti nell’ambiente archeologico vivevano un approccio che rifuggiva dall’impegno nel presente, spesso distaccato e nostalgico nei confronti di un passato percepito come un fardello. L’archeologia classica, in questo contesto, rischiava di diventare una pratica retorica, svuotata di una reale funzione politica e morale.
In uno dei suoi ultimi scritti, Bianchi Bandinelli espresse il suo disagio con l’etichetta di “archeologo”, sottolineando la sua differenza rispetto a coloro che si dedicavano esclusivamente alla raccolta di reperti materiali. La sua curiosità era rivolta verso il presente e il futuro, piuttosto che a un’esaltazione di culture passate.
Interpretare le sue parole solo come una dichiarazione di specializzazione nella storia dell’arte sarebbe riduttivo. Il concetto di una storia archeologica dell’arte si è evoluto grazie al suo approccio innovativo, spingendo a una comprensione più ampia e contemporanea del ruolo dell’archeologo.
Nel dicembre del 1972, intervenne a un convegno a Firenze per discutere l’importanza dei beni archeologici e la necessità di un approccio professionale nello scavo. Rama sottolineò che lo scavo archeologico distrugge i documenti, richiedendo una pianificazione attenta per evitare perdite irrimediabili. L’interesse per i reperti non può limitarsi a una mera curiosità; la disposizione degli oggetti racconta storie e offre indizi per comprendere il passato.
Il suo intervento evidenziava la necessità di diffondere una visione del patrimonio archeologico come documento storico, un legame che ci avvicina alla nostra storia familiare. La divulgazione non dovrebbe essere riservata a ristretti gruppi di esperti, e la sua critica si appuntava contro il retaggio idealistico che ha spesso travisato il valore degli oggetti archeologici.
La sua ricerca di un approccio inclusivo e comprensibile alle tematiche archeologiche rimane cruciale, soprattutto in un contesto attuale segnato da domande e sfide legate alla partecipazione e all’inclusività. Le riflessioni sull’universalità della cultura e su come affrontare le divisioni contemporanee sono rilevanti e urgenti.
Oggi, si percepisce la necessità di contrastare un’idea di cultura che spesso si divide in appartenenze conflittuali, con ripercussioni anche sul patrimonio culturale. È fondamentale promuovere un dialogo aperto che abbracci la storia e la scienza, superando l’ignoranza e affermando l’appartenenza collettiva al passato.
In questo contesto, l’universalismo assume un valore inestimabile, rappresentando un antidoto a sfide moderne e una guida verso una maggiore consapevolezza e inclusività.