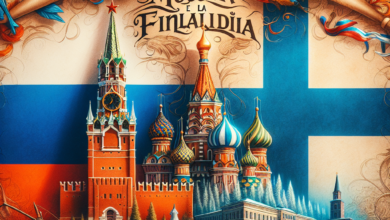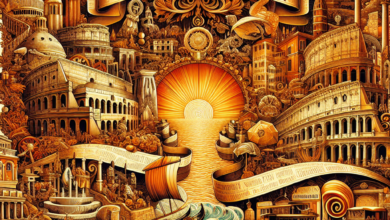Il crollo dell’Urss: speranze e tabù del passato.

Gli ottantacinque anni di Elena Aga Rossi evocano un altro anniversario. Nel 1995, trent’anni fa, organizzai un Convegno sulla storia comparata del Partito comunista francese e di quello italiano. Quell’incontro ebbe un prologo alla Luiss di Roma, dove presentammo l’edizione italiana del libro di François Furet, una delle prime grandi sintesi sulla storia politica del XX secolo. Oltre a Furet, erano presenti Renzo De Felice e Annie Kriegel. Victor Zaslavsky, in quell’occasione, tenne una relazione sulle potenzialità degli archivi dell’ex Unione Sovietica, appena divenuti disponibili, per il rinnovamento della storiografia. Si stava vivendo una fase di grandi aspettative.
Quei maestri, pur nelle loro differenze, condivisero la visione della storia come qualcosa di profondamente distinto dalla lotta politica. Speravano in un cambiamento duraturo, convinti che la ricerca della verità potesse prevalere sullo scontro ideologico e che la storia politica potesse uscire dall’orbita dei riferimenti di partito. Tuttavia, si dovette presto riconoscere che le complessità erano superiori a quanto previsto.
L’uso pubblico della storia intraprese, da quel momento, percorsi più contorti e meno apertamente strumentali. Tuttavia, la sudditanza nei confronti delle passioni politiche rimase forte. Per l’Italia, si potrebbe delineare un percorso storiografico parallelo al conflitto tra berlusconismo e antiberlusconismo che dominò gli anni tra il 1994 e il 2013.
Aga Rossi ha affrontato questi percorsi in maniera originale, aprendo nuove strade di ricerca su temi considerati tabù. Ha collegato la storia nazionale a scenari geopolitici più ampi, basando le sue analisi su documenti, anziché su teorie spesso influenzate da pregiudizi ideologici. In un contesto in cui l’eccessiva concettualizzazione ha talvolta impedito di affrontare verità evidenti, ha offerto una chiarezza di stampo anglosassone, garantendo che la storia non si riducesse a territori riservati a pochi iniziati.
Per tutte queste ragioni, la sua carriera non è stata semplice. Il suo libro sui motivi del Proclama Alexander, ad esempio, è passato inosservato; le sue ricerche sulla pluralità della resistenza e sulle esperienze dei militari all’estero l’8 settembre sono state considerate revisioniste; la sua documentazione sul ruolo di Stalin nella svolta di Salerno è stata a lungo giudicata come sovrastrutturale.
Questi esempi suggeriscono che il Convegno a lei dedicato potesse rappresentare un atto non solo dovuto, ma anche un risarcimento. Considerando chi ha partecipato e il loro peso, orientamento e generazione, si può pensare che, rispetto a trent’anni fa, il tempo non sia trascorso invano.