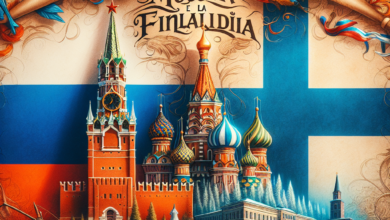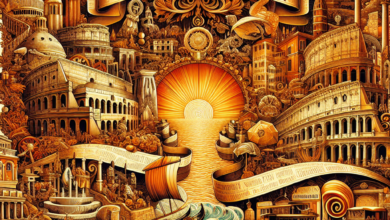Il silenzio sulla sofferenza della Rivoluzione culturale in Cina

Sono trascorsi quasi sessant’anni dall’inizio della Rivoluzione Culturale, un periodo di profonda trasformazione voluto dal presidente cinese Mao Zedong, che durò dieci anni, fino alla sua morte nel 1976. Tra il 1966 e il 1976, la Cina visse una sorta di rivoluzione permanente, in cui l’unico imperativo era la fedeltà a Mao, con una popolazione di 800 milioni che ricevette cinque miliardi di spillette in alluminio con il suo volto.
Questi eventi furono talmente eccezionali che la Corea del Nord, associata al culto del leader, la definì come «una grande follia, che non ha niente a che vedere né con la cultura né con una rivoluzione». Fu un decennio di instabilità violenta, con oltre due milioni di morti e innumerevoli feriti. Famiglie distrutte, istituzioni educative compromesse e un patrimonio culturale inestimabile ridotto in macerie dalla foga iconoclasta delle Guardie Rosse, tutto con l’approvazione di Mao.
Le università e le scuole vennero chiuse e si attuò un rigoroso controllo del pedigree rivoluzionario familiare, con severe persecuzioni nei confronti di chi era considerato critico nei confronti di Mao. Il potere personale di Mao si scatenò per vendicarsi di un partito comunista che cominciava a chiedere conto delle sue scelte, in particolare riguardo al Grande Salto in Avanti, un progetto economico che causò la morte di decine di milioni di persone.
In risposta alle critiche, Mao dichiarò ogni obiezione anti-rivoluzionaria e sfruttò l’idealismo giovanile per eliminare i suoi nemici, compresi quelli che un tempo considerava amici. Quando la situazione divenne insostenibile, Mao inviò milioni di giovani nelle campagne, «a imparare dai contadini», spezzando famiglie e impedendo loro di tornare per anni.
Dopo il 1976, ci sono stati momenti in cui ci si è potuti esprimere riguardo alle atrocità del maoismo, seppur con limiti stringenti. Le opere letterarie emerse poco dopo la morte di Mao si sono concentrate principalmente sulle vittime, senza approfondire le responsabilità e le cause di tanto dolore.
Memoria e tabù
Il racconto spesso si articola in reportage, con visite nei luoghi segnalati dalla Rivoluzione Culturale e interviste a persone con esperienze significative. Si dialoga con psicologi, psicoanalisti, vittime e loro carnefici, esplorando storie di violenza e tradimento che hanno segnato le vite di molti. Il caos di quel periodo, voluto dal presidente, rimane un capitolo complesso, con il ricordo di Mao che persiste in piazza Tian’anmen e nel quotidiano.
Ripercorrendo le vite di chi è stato toccato da quel decennio, si evidenziano i legami tra gli eventi passati e la frenesia della Cina attuale, caratterizzata da momenti di ferocia e un individualismo diffuso, in un contesto dove la modifica della storia è una realtà. La memoria e la smemoratezza sono due facce della stessa medaglia, con gli echi di un passato buio che continuano a influenzare il presente.