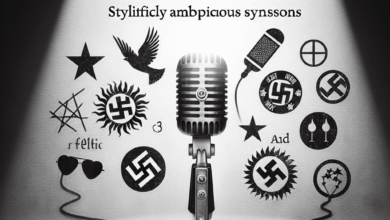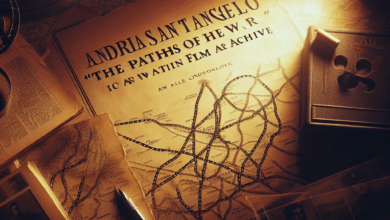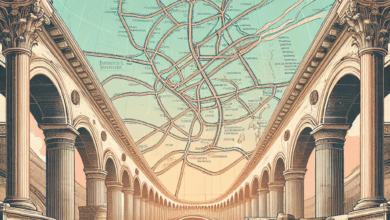Dalla visione di Tocqueville alla democrazia post-1989
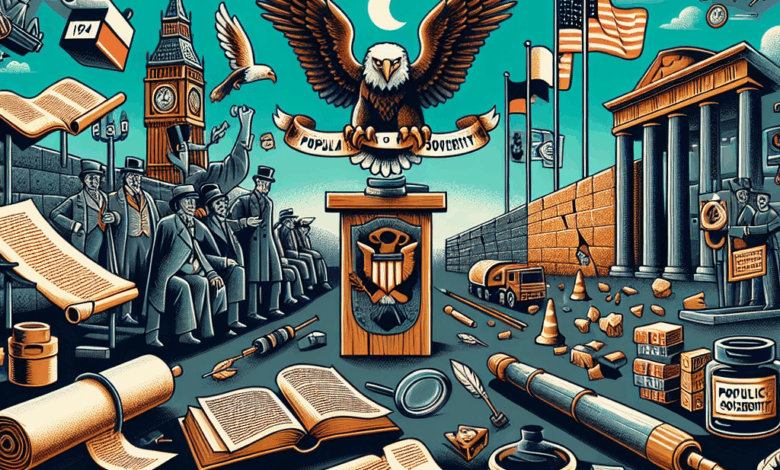
Nelle note di viaggio in Inghilterra, redatte nel 1833, si afferma che «il secolo è primariamente democratico. La democrazia è come una marea montante; si ritira solo per tornare con maggiore forza, e presto si rende conto che, nonostante tutte le sue oscillazioni, continua a guadagnare terreno. Il futuro immediato della società europea è completamente democratico».
Oggi, alla luce di una crisi della democrazia rappresentativa – evidenziata dallo scollamento tra leader e le esigenze di molti cittadini – ci si chiede se questa affermazione abbia ancora valore.
Quando si redigono le note sulla marea montante della democrazia, si è in procinto di lasciare l’Inghilterra, interrogandosi sulla possibilità che anche il Regno Unito sperimenti rivoluzioni simili a quelle della Francia. La prognosi è che le istituzioni britanniche sfuggiranno a tale destino, avviandosi verso una trasformazione graduale sempre più democratica, intesa come più egualitaria nelle relazioni sociali.
CIRCA UN PAIO di secoli dopo, si apprezzano la lucidità di queste osservazioni e si confermano le preoccupazioni: in alcune circostanze la marea può risultare devastante. Le rivoluzioni, anche quelle con buone intenzioni, spesso generano conseguenze negative per la libertà e l’uguaglianza. In contesti estremi, a soffrire sono anche coloro che sperano in una società giusta.
PER I CONSERVATORI, nel corso del Novecento, il monito assume particolare rilievo alla luce delle grandi rivoluzioni come quella russa e cinese. Se la marea è irresistibile, l’unica strategia è assecondarne la forza, disperdendola in rivoli diversi per minimizzare i danni. È per questo che molti conservatori nella seconda metà del Novecento accettano i termini del “consenso socialdemocratico”: tasse alte, intervento pubblico nell’economia e welfare. Questi anni coincidono con il rafforzamento e l’espansione della democrazia in Europa e negli Stati Uniti, diventando un “modo di vita” tutelato da costituzioni e leggi.
DOPO IL 1989, il consenso socialdemocratico inizia a vacillare. Si impone una nuova visione, secondo cui la marea ha esaurito la propria forza, destinando le acque a calmarsi. Ma è possibile dimenticarsi della marea? È necessario riconsiderare le osservazioni in una prospettiva nuova.
A SPINGERE l’onda della democrazia era il vento della modernità economica, che richiedeva il superamento dei vincoli delle società tradizionali per liberare le capacità produttive. Questo porta a una democratizzazione, come riconosciuto, ma la forza del cambiamento dipende da forze materiali, come intuì Marx.
Ritenere possibile regolare queste forze senza mettere in discussione i rapporti di potere e la distribuzione della proprietà è alla base della cultura politica di molte classi dirigenti recenti. Le diseguaglianze aumentano, la libertà si restringe, e la democrazia diventa un termine sempre più vago. Il drammatico scollamento tra figure politiche di rilievo e una parte crescente delle opinioni pubbliche occidentali deriva dalla riluttanza a confrontarsi con questi nodi cruciali.
LA DESTRA HA FATTO una scelta chiara, il cui esito potrà essere un ridimensionamento della democrazia, e forse la sua scomparsa nei contesti dove si afferma l’autoritarismo. La modernità suggerita da certa élite del capitalismo high-tech è caratterizzata da sorveglianza capillare e punizione del dissenso, con forme sempre più brutali, e in futuro persino letali. L’aspettativa per chi non appartiene alle élite di queste società post-democratiche è quella di piegarsi, diventando flessibili e disponibili per i ruoli a essi assegnati.