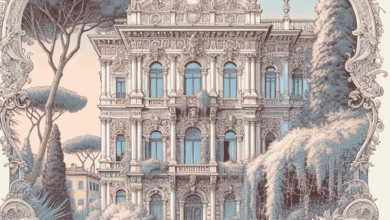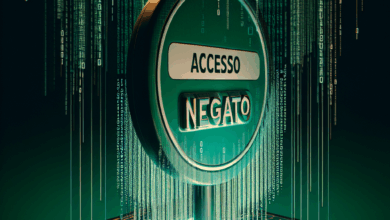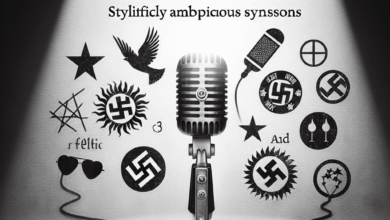Sindemia, guerre e capitalismo delle emergenze: un legame stretto.
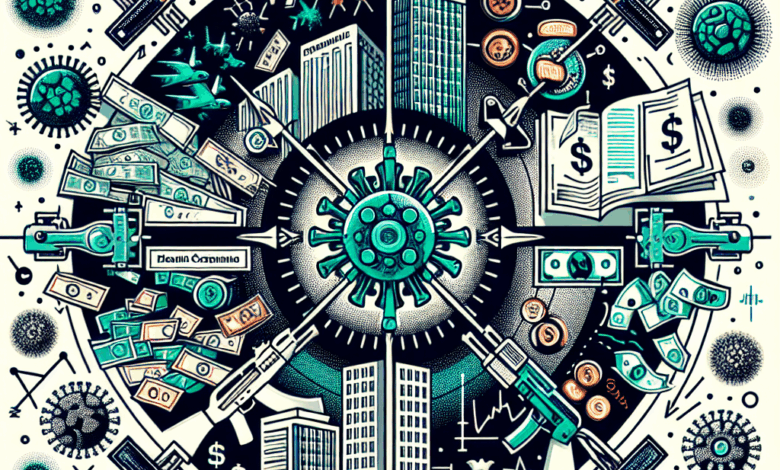
La pandemia/sindemia è finita il giorno in cui è iniziata la guerra in Ucraina. Quest’ultima ha perso di interesse quando è iniziata quella a Gaza. Il capitalismo delle emergenze agisce nel mezzo del caos creato dai suoi stessi agenti, permettendo a chi governa di adottare misure altrimenti inaccettabili grazie alla propaganda delle emergenze. Come si giustificherebbe la politica di riarmo europeo dopo una pandemia che ha evidenziato la drammatica crisi del sistema sanitario pubblico? Ora i tagli al welfare non suscitano scandalo, nonostante prima si accettassero la sorveglianza autoritaria dei coprifuoco e le misure discriminatorie come il green pass e l’obbligo vaccinale, mentre bambini e adolescenti erano costretti a rimanere chiusi in casa. Tutto ciò avviene in nome della “sicurezza” sanitaria mentre si finanziano guerre. Come non notare l’assurdità di queste narrazioni?
Eppure una continuità c’è. Cosa hanno in comune la pandemia/sindemia iniziata nel 2020, il conflitto in Ucraina e la brutale strategia di espulsione forzata dei palestinesi? Ogni emergenza è gestita in modo simile, ridicolizzando le voci dissidenti e sminuendo ogni critica legittima.
Per quanto riguarda l’invasione russa, si è preferito ignorare la violazione degli accordi di Minsk. E per quanto riguarda lo sterminio in Medioriente? Invece di pressare per la liberazione dei territori occupati, si etichettano come antisemiti coloro che chiedono un cessate il fuoco.
Se non si comprende che questi eventi fanno parte di un unico mosaico, si rischia di cadere nella trappola della propaganda, che oscura gli aspetti sistemici e strutturali del disastro contemporaneo. Privatizzazioni, riarmo, controllo dell’informazione, riduzione al silenzio della critica democratica, precarizzazione crescente della vita e del lavoro, e penetrazione del capitale finanziario sono i vettori attuali, sotto il comando delle élite politiche.
Anche a livello locale, come a Milano, si notano le stesse dinamiche: privatizzazioni selvagge, speculazioni e squalificazione del conflitto sociale, con un’attenzione crescente al business e all’opacità dei sistemi di controllo della politica.
Un’analisi del passaggio da una città basata sulla produzione e il lavoro sociale a una città “attrattiva” mostra come si stia creando un’immagine in grado di attrarre flussi finanziari a breve termine, espellendo il ceto medio e gravando sulle classi sociali più fragili. I fondi per i servizi pubblici e la manutenzione dei beni comuni sono stati progressivamente ridotti, con spazi pubblici svenduti e condizioni di abbandono in quartieri popolari.
In questo contesto, il conflitto viene affossato. Le organizzazioni locali che raccolgono proteste e offrono servizi vengono spesso inglobate in un sistema di finanziamenti che limita la critica e impone progetti dall’alto, contribuendo alla privatizzazione dei servizi. Questa strategia svuota di contenuto politico i movimenti sociali, trasformandoli in strumenti utili a processi di speculazione urbana.
È importante riflettere su come ripartire da un’idea di conflitto in grado di proteggere gli spazi pubblici, contrastare la rendita immobiliare e costruire strumenti per tutelare i beni comuni, promuovendo forme di socialità più giuste e accessibili. È urgente un dibattito politico che discuta delle necessità concrete dei cittadini, toccando questioni di ogni ordine, dalle città agli equilibri globali. Nessuno potrà evitare la catastrofe aspettando che “passi la nottata.”