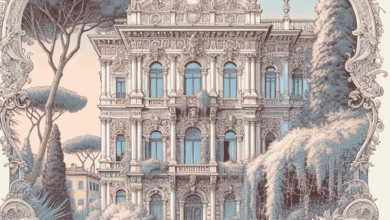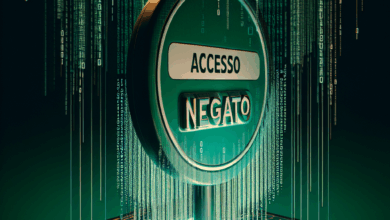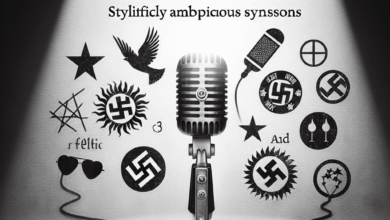L’America esausta dal gravare il mondo intero.
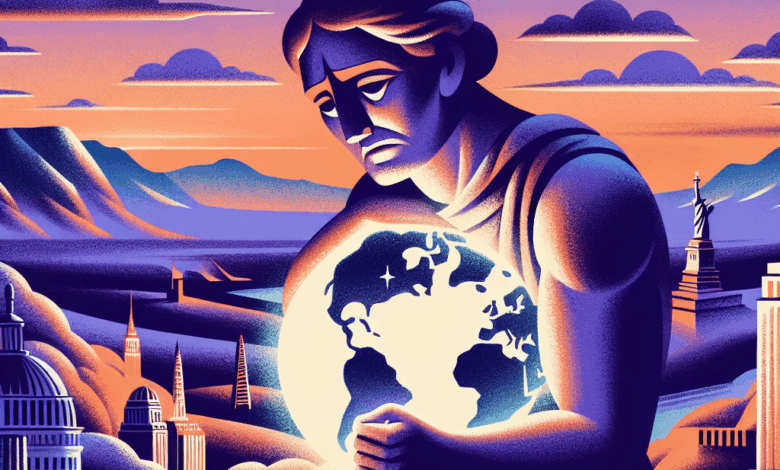
Per quasi ottant’anni, l’Europa ha vissuto sotto l’influenza dell’Impero americano, che ha garantito pace, stabilità e prosperità a seguito di un compromesso storico nel dopoguerra. Gli Stati Uniti, usciti vittoriosi dal secondo conflitto mondiale, decisero di rimanere nel continente, non solo militarmente, ma anche attraverso piani economici come il piano Marshall e l’architettura di Bretton Woods.
Questa scelta non fu solo altruistica, ma seguì una logica imperiale: sostenere alleati strategici in cambio di influenza e legittimità globale. Gli Stati Uniti si impegnarono a finanziare la sicurezza dell’Europa occidentale, garantendosi così un posizionamento strategico contro l’Unione Sovietica e un ruolo attivo nella proiezione globale.
Il Mediterraneo si trasformò nel lago della Nato, mentre l’Africa rappresentava un campo di gara geopolitica. In questo contesto, l’Europa poteva concentrarsi sullo sviluppo delle proprie democrazie, grazie alla protezione fornita dagli Stati Uniti, che si occupavano della difesa collettiva.
L’imperialismo americano, dopo la guerra, si fondava non sull’occupazione diretta, ma su una rete di sicurezza e connessioni che includevano basi militari e accordi commerciali. Questo sistema ha mantenuto un ordine globale che, pur con contraddizioni, ha garantito stabilità e prestigio.
Ora, però, questo contratto sembra infrangersi. Le recenti critiche alla strategia europea da parte degli Stati Uniti rivelano un cambiamento nell’atteggiamento, con una crescente riluttanza a mantenere il ruolo imperiale. Gli eventi in Medio Oriente e le incertezze riguardo al sostegno a Kiev indicano una perdita di chiarezza strategica. Inoltre, l’emergere di influenze globali, come quella cinese in Africa, testimonia una superpotenza con crescenti problemi interni.
Questo cambiamento non è casuale. Le nuove correnti politiche negli Stati Uniti, come quella rappresentata da “America First”, evidenziano un sentimento di crescente stanchezza nei confronti degli impegni internazionali. Questo approccio porta a considerare le alleanze come costi da ridurre e privilegia la sicurezza interna rispetto a interventi esterni.
Il vuoto lasciato da una possibile riduzione dell’influenza americana non tarderà a essere colmato da potenze più aggressive. Si osserva un incremento di attività da parte di Russia, Iran, Turchia e Cina, con implicazioni significative per gli equilibri geopolitici, mentre l’Europa rimane in una posizione di dipendenza e incertezza.
In questo contesto, l’Italia tenta di avviare una nuova strategia con il suo Piano Mattei per l’Africa, ma senza un percorso strategico comune, rischia di essere un’iniziativa isolata. La fine dell’egemonia comporta costi elevati e, senza una credibile alternativa, le forze centrifughe e autoritarie potrebbero prendere piede. La questione va oltre gli interessi americani; riguarda il bilanciamento globale e la definizione stessa di Occidente. L’era di un potere stabilizzatore sembra finire, ma è cruciale comprendere il valore di un sistema di ordine globale prima che sia troppo tardi.